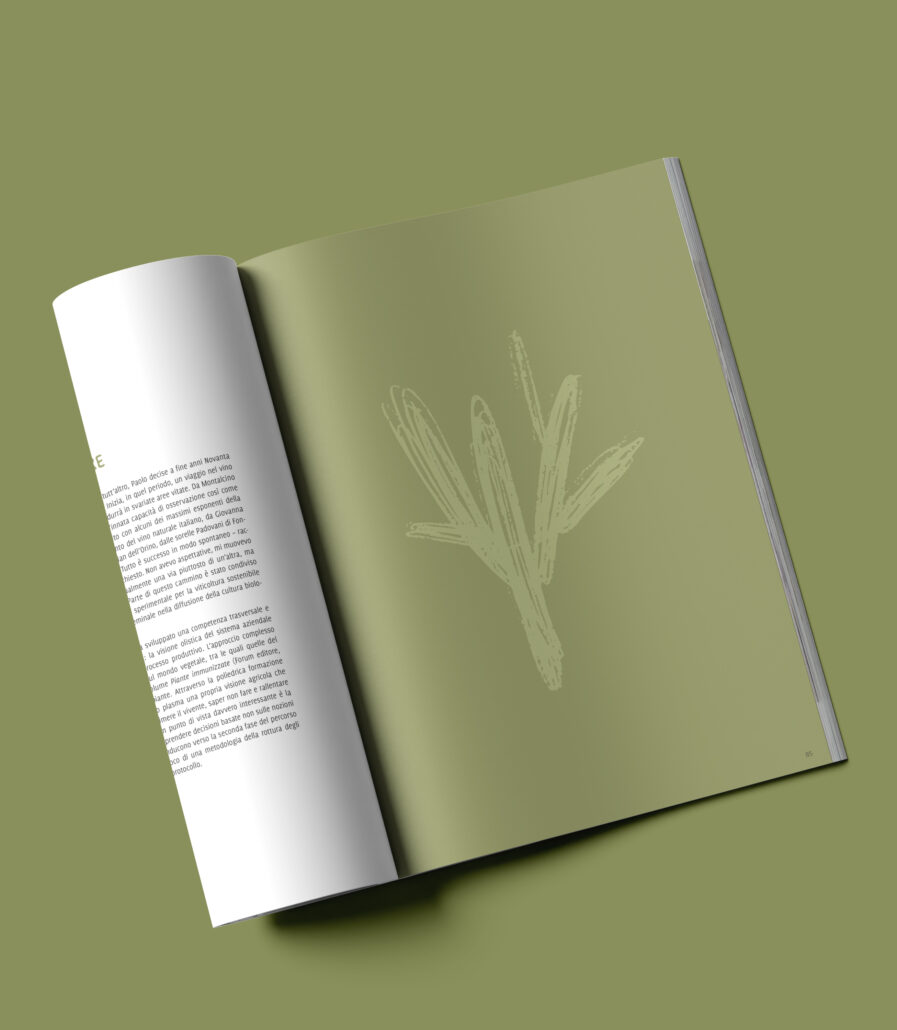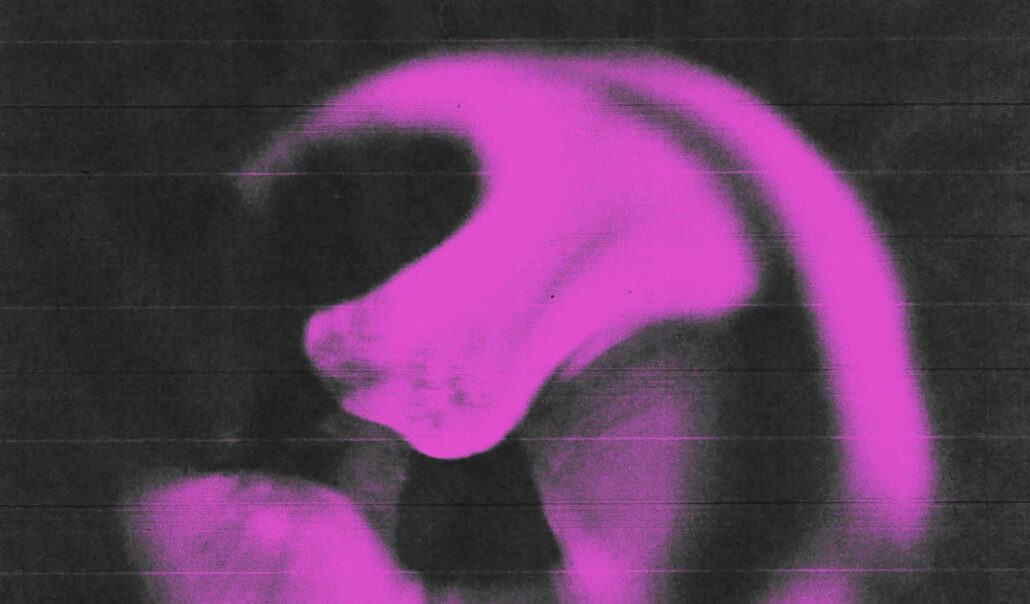Qualcuno lo soprannomina superfood, qualcuno lo consuma solo nella zuppa al ristorante fusion all you can eat, qualcun altro lo produce in casa. Quest’anno, un team di ricercatori ha persino provato a fermentarlo nello spazio (vien fuori che assume un sapore nutty, di frutta a guscio). Viene dal Giappone con una storia che affonda le proprie radici in Cina; è il miso e vi ci sarete imbattuti anche voi: nel menu di un ristorante fine dining, al supermercato nella sezione dal mondo, nei consigli nutrizionali di qualche magazine che raccomanda di consumarlo in quanto fonte di probiotici importanti per l’apparato digerente.
È tutto vero: il miso apporta contributi molto interessanti alla cucina non solo orientale.
È un fermentato positivo per l’organismo umano e qualcuno lo definisce, con contezza di causa, il miglior svuotafrigo in circolazione. Un attimo, forse così è troppo: riavvolgiamo.
Del miso si hanno tracce fino da duecento anni prima della nascita di Cristo (ma la prima menzione ufficiale su un reperto scritto è datata 701 d.C., all’interno del codice Taiho). Nel contemporaneo è associato al Giappone e alla sua cucina, eppure le sue origini sono legate alla Cina e a un fermentato di soia chiamato chiang. All’inizio della sua diffusione, il miso è un ingrediente di lusso. Mai usato come cibo a sé stante, viene messo a disposizione di nobili e cavalieri per dare un guizzo in più al desinare. Le prime popolarizzazioni si ebbero con i monaci buddhisti nella prima metà del primo millennio, e poi, nel periodo Muromachi (a partire dal Quattordicesimo secolo), le coltivazioni di soia aumentarono e anche i contadini cominciarono a replicare la preparazione. Oggi il miso, che è una pasta densa dal colore variabilmente bruno-dorato, di cui esistono diverse varietà, ha assunto uno status analogo a quello della pasta madre dei lievitati quando si tratta di domesticità e tradizione: ognuno lo fa a modo proprio e probabilmente “quello della nonna è sempre più buono”.
Nonostante tutto questo parlare di soia, però, il miso non parte dal legume. Il processo si attiva con la creazione del koji, ovvero un composto fermentato di cereali. In Giappone si usa tipicamente il riso, o l’orzo, a cui si inocula un tipo di fungo, l’Aspergillus oryzae. I chicchi vanno dunque lasciati fermentare per un tempo a scelta, o meglio: diverse lunghezze di invecchiamento del koji produrranno diversi risultati sul miso finale. Il passaggio seguente, una volta raggiunto lo stadio di maturazione desiderato, sta nell’unire il koji al vero e proprio ingrediente da trasformare, da cui ricavare il miso. La tradizione giapponese vuole i fagioli di soia, ma è pure vero che il solo Giappone vanta circa un migliaio di varianti di miso, in quanto ogni area geografica ne produce a modo suo. Perciò, possiamo considerare la nozione di una tradizione “estesa”, dove non tutti fermenteranno con fagioli di soia. A ogni modo, vanno poi aggiunti sale e acqua, e ancora una volta, via a lasciar maturare per il tempo desiderato.

“I cereali di partenza danno complessità diverse al risultato finale, così come la scelta dell’ingrediente principale, che apre la strada a un percorso inesplorato nel gusto. L’apparente semplicità di partenza richiede però conoscenza tecnica e molte accortezze lungo tutto il processo”.
A parlare è Francesco Sodano, chef alla guida dello stellato Ristorante Famiglia Rana, nella campagna veronese. Non è stato lui a definire il miso uno strumento per svuotare il frigorifero di tutti gli avanzi, ma il ruolo del miso e delle fermentazioni tutte nella cucina di Sodano non cambia: rendere il più possibile circolare il processo, trasformare ogni scarto in una virtù. Mi spiega il suo piatto Eliche, pane e olio, per esempio: “Non vogliamo sprecare le eccedenze di pane e di pasta e allo stesso tempo li vogliamo usare come veicoli per valorizzare un ingrediente in teoria di seconda scelta. Con il riciclo del pan brioche realizziamo un miso che matura da anni e che usiamo come insaporitore inaspettato”. Non solo: “Nella Capasanta e prosciutto, giochiamo con le sensazioni e l’aroma di quest’ultimo ingrediente e l’ospite termina l’assaggio con il miso di pistacchi, giovane e pronto già dopo quattro mesi. Se di solito si cerca di togliere la parte grassa della frutta secca dal miso perché rischia di irrancidire, il risultato che abbiamo ottenuto mantenendola è proprio la sensazione aromatica del grasso del prosciutto”. E infine, “abbiamo creato il piatto Semi di zucca lavorando su tutte le componenti di questo seme, realizzando anche un miso stravecchio (di sei anni) che dà una nota umami che diventa un’esplosione di sapore”. Il miso di Sodano è libero, creativo, esplosivo.
Alcuni suoi colleghi lo trattano con filosofie simili ma applicazioni più conservative, senza che questo sia una nota di demerito. Un esempio è Francesco Brutto del Venissa nella laguna veneziana, dove cucina back to back con Chiara Pavan (la loro squadra si è portata a casa sia una stella Michelin, che una stella verde). “Io credo che tutto quello che non è fatto con orzo, soia e riso non sia e non debba essere chiamato miso. Poi, l’evoluzione della cucina si fonda soprattutto sulla contaminazione tra popoli e culture, quindi non ci vedo niente di male a provare a fare cose nuove e diverse”. Al Venissa, un esempio di uso del miso si trova in una “crema con una sorta di miso fatto a partire interamente dai fagioli cannellini, accompagnata a pesce serra, amaranto e alghe”.
Alla conversazione si aggiunge Maurizio Bufi, chef dello stellato Il Fagiano sul Lago di Garda, inserito nel contesto prestigioso del Grand Hotel Fasano. “Ci sono generalmente due tipi di miso: chiaro, che ha una fermentazione breve, e scuro, un miso a base d’orzo che richiede una fermentazione lunga. Il miso chiaro ha un sapore più delicato e leggermente dolce, mentre lo scuro ha un sapore più forte, deciso e sapido. Utilizzo il miso d’orzo nel piatto Plin di coniglio, funghi shiitake, miso d’orzo del menu Contaminazioni. Nella mia cucina uso anche il miso chiaro, all’interno di un brodo da ramen. Questo miso richiede circa un anno di fermentazione. Il brodo di questo ramen lo preparo con pollo tostato, miso chiaro, funghi shiitake e champignon, alga nori, brodo di pollo, katsuobushi e salsa di soia”.
Il miso è con noi da un po’, in Occidente.
La competenza degli chef e dei fermentatori è alta e la creatività non manca. Lo zampino fu quello di René Redzepi, che nel 2009 cominciò a preparare il koji nel laboratorio del Noma. Fu proprio il miso, almeno da quanto si legge nei loro bollettini, a dare l’avvio al più vasto interesse per il mondo delle fermentazioni diventato poi sinonimo della New Nordic Cuisine. Ancora Sodano: “La cucina nordica su preparazioni come il miso e altre fermentazioni ha insegnato molto e ha aperto una strada anche nel fine dining in Occidente. Ma il miso in Oriente si prepara per tradizione in un contesto domestico, è un know how che si tramanda. A Copenaghen ho assaggiato da una signora coreana il miso che preparava sua nonna. C’è chi ha la fortuna di conservare e di tramandare non solo un sapere ma anche un ingrediente vivo”.
Storia alternativa, in questo contesto è quella di chef Brutto: “Il miso credo di averlo scoperto quando da ragazzetto si andava nei ristoranti di sushi finti e ti portavano ‘sta zuppa di miso annacquata. Poi il miso ‘vero’ quando a Treviso hanno aperto un negozio che importava direttamente dal Giappone alimenti e ceramiche, credo fosse il 2006. Poi ho un ricordo di un piatto di Crippa: il baccalà laccato al miso”. Il concetto di maestro dunque, nel miso, è sfumato e addirittura inessenziale. Perché, al netto di rigorose tecniche di preparazione, è un prodotto che si affida alla disponibilità di quello che c’è in giro.
Non per nulla, così come accade per il kimchi coreano, miso è un nome che si riferisce alla tecnica di preparazione e non direttamente al suo ingrediente principale.
A “miso” si aggiungono diversi termini a seconda delle materie di partenza e del tempo di fermentazione. Insomma, a volerla fare filologica, un bel casino – sempre per tornare sui nostri lidi, al Ristorante Famiglia Rana il miso è prodotto, per esempio, di pomodoro, ceci, pane, pompelmo e semi.


E sulla lingua? Manco a dirvelo, il miso è umami, forse uno dei migliori esempi di. Da qui il suo potere di insaporitore ed esaltatore.
Ma, anche se il sapore potrebbe prendere contropiede, “la cultura gastronomica italiana in realtà ha tante preparazioni che hanno a che fare con le fermentazioni, le persone per questo ne hanno spesso più familiarità gustativa di quello che immaginano. La giardiniera nasceva come una lattofermentazione, il ketchup era una salsa di acciughe fermentate prima ancora dell’aggiunta di pomodoro. Una delle preparazioni più antiche attestate già in epoca romana era il garum, una fermentazione di esce giunta fino ai giorni nostri”, così ricorda Francesco Sodano. Al tavolo del ristorante, comunque, “generalmente la clientela non conosce il miso. Ne ha sentito parlare, ma non c’è ancora una cultura importante del miso in Italia. Quando i clienti lo assaggiano, si accorgono che ha un gusto interessante, sapido e intenso, tanto che noi in cucina lo diluiamo”, racconta Bufi. Mentre dalle parti del Venissa succede che “tendiamo a non sottolineare tutte le tecniche che usiamo durante la descrizione del piatto, ma a focalizzarci di più sul contenuto del messaggio che vogliamo veicolare. Quindi tendiamo a omettere molte cose riguardanti la fermentazione perché per noi fanno semplicemente parte di un vocabolario acquisito”.
Su una cosa, sicuramente, i tre chef concordano: il lato davvero tecnico della produzione di miso nel contesto di un ristorante. Quando sì, certamente, si può sbagliare e riprovare, soprattutto in fase di sperimentazione. Ma poi, quando si deve andare sul sicuro, bisogna essere in grado di effettuare controlli scrupolosi sulla temperatura di fermentazione (idealmente attorno ai 30°C), sull’umidità (al 70-80%, specifica Sodano) e pure sul PH della preparazione, che deve mantenersi basso. Anche solo una dosa sbagliata di sale può compromettere il risultato, o una cattiva manutenzione e pulizia degli ambienti di fermentazione.
Insomma, la prossima volta che vi troverete fuori a mangiare, magari proprio in uno stellato o un ristorante di cucina raffinata, fateci caso: quel bel sapore che sentite, appunto quell’umami, potrebbe essere dato da un ingrediente segreto e ormai molto più occidentalizzato di quello che potreste pensare. E chissà che, sedendovi a chiacchierare con chi l’ha preparato, non imparerete qualcosa di nuovo…