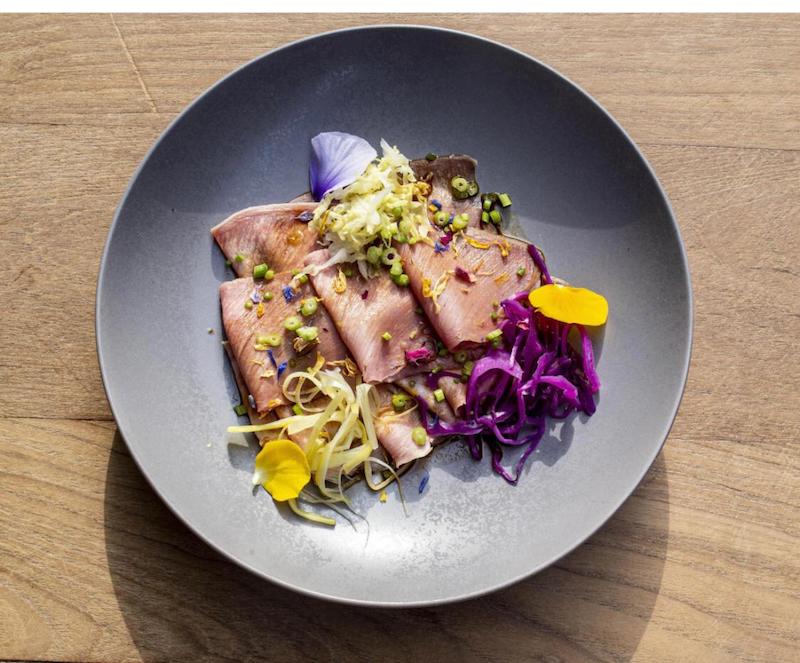Tre giorni, tre borghi, un’idea semplice ma potente: recuperare. Non solo cibo, ingredienti, energie, ma storie, relazioni, territori. Dal 29 al 31 agosto torna il Festival del Recupero, nell’Appennino tosco-romagnolo. Siamo arrivati alla quinta edizione e ormai possiamo dirlo: questo non è (solo) un festival gastronomico. È la dimostrazione che si può parlare di sostenibilità senza risultare pesanti, fare cultura senza spocchia, divertirsi mangiando ciò che altrove sarebbe finito nel compost (nella migliore delle ipotesi), conoscere artigiani veri e stupefacenti… il tutto con una visione concreta di consapevolezza ambientale, culturale e sociale.
Quest’anno si alza l’asticella: Pianetto di Galeata resta il cuore pulsante, ma si aggiungono anche San Piero in Bagno e Santa Sofia. Il programma? Talmente ricco che viene voglia di prenotare solo per il gusto di non capire dove iniziare. Cene d’autore, foraging, gelati fuori dagli schemi, pizze gourmet, picnic della foresta, cocktail sostenibili, tour in e-bike, convegni tra cui quello su Foresta e acqua, l’equilibrio della montagna e le buone pratiche del recupero dei territori, il consueto mercato dei produttori del recupero, laboratori e tutto un programma interattivo dedicato ai bambini. E soprattutto una grande comunità che si ritrova ogni anno per costruire qualcosa di più di un evento. Qualche nome dei partecipanti per stuzzicare le papille: Gianluca Gorini, Valerio Serino, Fabio Ingallinera, Luigi Lepore, Giacomo Devoto, Antonio Ziantoni, Giulio Gigli, Yoji Tokuyoshi, Juan Camilo Quintero, Stefano Guizzetti, Giulio Rocci, Jimmy Bertazzoli, Enrico Gori, Michele Di Carlo. Ma il programma completo si trova qui.
Dietro tutto questo c’è l’Associazione Tempi di Recupero e, soprattutto, c’è lui: Carlo Catani, ideatore, animatore, presidente e cuore pulsante del progetto. A lui abbiamo fatto qualche domanda per capire cosa c’è dietro (e davanti) a questa edizione 2025. E cosa si recupera davvero, in questo festival.


Il Festival del Recupero di quest’anno è itinerante tra tre borghi: come si è arrivati a questa scelta e quali sono le altre novità di quest’anno. E cosa rende Pianetto di Galeata un luogo così speciale rispetto ad altri borghi della Romagna per essere da sempre il centro del Festival del Recupero?
Da sempre ci piace l’idea del recupero dei territori “diffusi”, per cui che non sono caratterizzati dai confini comunali, ma che si caratterizzano per storia, cultura e problematiche al di là dei “campanili”. Per questo già da un po’ di anni, cerchiamo di mettere insieme – attraverso la cena dei sindaci (il gran finale della domenica 31 agosto, ndr) – i territori e i loro valori. Fin dall’inizio del Festival abbiamo avuto la presenza della cena del Recupero della Montagna che ha visto coinvolto sempre il nostro socio Gianluca Gorini, per cui, come in un percorso naturale, anche il Comune di Bagno di Romagna si è unito alle attività del Festival. In questo lo splendido borgo di Pianetto di Galeata, sede dell’Osteria della Campanara, nostro partner nell’organizzazione del festival sin dalla prima edizione, incarna i nostri valori e racconta il territorio nella maniera che ci piace, per cui è certamente una location che condivide i nostri valori e quest’anno celebra anche i 20 anni di attività, quindi doppia festa.
Come sta evolvendo, secondo te, il concetto di “recupero” in ambito gastronomico e culturale, e quali nuovi orizzonti vedi per Tempi di Recupero nei prossimi anni? Qual è la sfida più grande nel trasmettere un messaggio di sostenibilità che sia al tempo stesso concreto, accessibile e coinvolgente?
Oggi l’attenzione ai temi del recupero e dell’uso integrale delle materie prime è sicuramente molto diversa da quando abbiamo iniziato a svolgere la nostra attività associativa. Ossia c’è sicuramente molta più attenzione per quello che riguarda gli chef del fine dining, sempre molto refrattari ad affrontare il tema degli avanzi, per quello che riguarda l’uso integrale delle materie prime (il quinto quarto è sdoganato da tempo) e tutti quelli che sono temi volti alla comunicazione della storia dei prodotti utilizzati e della conseguente ricerca che c’è dietro, diventa una chiave narrativa di valore per tutti. Per questo ritengo che comunicare la rete e la propria ricerca, diventi un lavoro indispensabile per comunicare il proprio territorio, e una chiave importantissima per valorizzare il proprio lavoro.



Come si costruisce e si mantiene viva una rete così ampia e variegata senza perdere autenticità e coerenza nel messaggio? In che modo la forza della rete tra chef, artigiani e territori trasforma singoli gesti di recupero in un vero e proprio movimento culturale?
Non so se c’è un segreto o una formula, noi per quello che ci riguarda, cerchiamo di valorizzare anche le differenze di idee e di interpretazioni, cercando di ascoltare il più possibile la rete. Queste differenze possono essere una ricchezza, fatto salvo la condivisione dei punti che proponiamo agli aderenti della rete, che devono esser condivisi, un po’ come punti di partenza, ma senza poi togliere libertà ad o ogni soggetto, di interpretare strade possibili a modo suo.
La postazione gelati del recupero coinvolge gelatieri da tutta Italia: cosa significa per voi il gelato come veicolo di sostenibilità e recupero in un evento gastronomico così ampio?
Il gelato è un prodotto straordinario. È pop ed apprezzato da tutti, ma raccontato dai grandi professionisti della nostra rete, può fare capire a tutti, che tipo di ricerca e collaborazione con i produttori di materie prime, può esser dietro alla realizzazione di un gelato. Anch’esso può essere un prodotto unico, e con una storia da raccontare, e quindi diventare uno strumento della narrazioni e della ricerca, da utilizzare nella rete.
Come è cambiata la vostra visione del recupero dal primo evento nel 2013 fino ad oggi? Quali sono i valori fondamentali che guidano la rete di Tempi di Recupero e che la distinguono da altre realtà simili?
Nel 2013 realizzavamo principalmente cene puntando all’interpretazioni di Avanzi, quinto quarto e recupero della tradizione a rischio scomparsa, oggi siamo una rete complessa di professionisti ed appassionati che prova a prevenire gli sprechi attraverso l’uso integrale delle materie prime e le pratiche di cucina circolare. Oggi quello che probabilmente ci distingue è la volontà dell’associazione di essere inclusivi ed accoglienti, anche come linguaggio. Non ci piace né il modo contrappositivo di tante comunicazioni adottate oggi, né quello che presuppone di essere in possesso di verità, che in una società complessa come quella attuale, sono difficili da metter a fuoco.
Nel mondo del recupero, quali sono le “piccole ribellioni” che vedi emergere e che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo al cibo e alla sostenibilità?
Sicuramente il ritorno a realtà agricole multi e poli funzionali, che si allontanano dalle specializzazioni e dalle monocolture, per abbracciare progetti resilienti e che recuperano quello che una volta era standard per quasi tutti gli agricoltori. Altre come recupero di territori montani, come quello del Reis in Val Varaita o quella di Valle Ponci (entrambi presenti al Festival), dove le realtà multifunzionali, si sposano con l’interpretazione dei prodotti stessi trasformando i prodotti in grandi piatti, credo che queste possano rappresentare “le ribellioni” che possono cambiare il futuro della comunicazione di un cibo sostenibile.
Ci vediamo in Romagna a fine agosto!